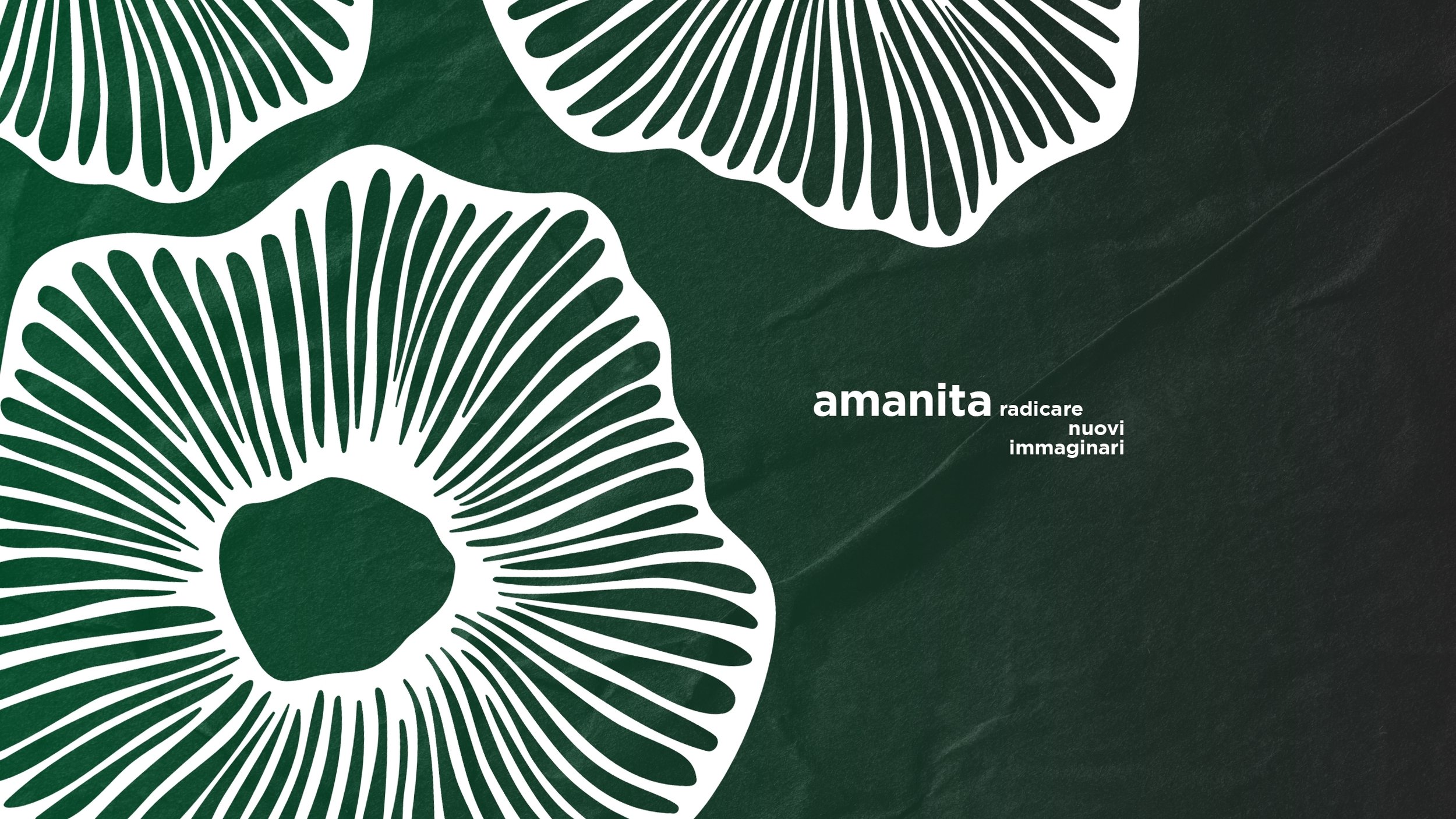Mediterraneo: salvare vite in assenza di vie legali
di Veronica Gennari
copyright Emergency
«Ricordatevi che non siamo eroi, siamo solo persone che aiutano altre persone», dice Anabel Montes Mier, la SAR Coordinator (capo missione) sulla Life Support, la nave search and rescue della ONG Emergency, al suo equipaggio. Decine sono le missioni di salvataggio in mare portate a termine con successo dalla Life Support dal 2022, anno in cui l’ONG ha iniziato a lavorare nel Mediterraneo per cercare di salvare vite di persone in pericolo in mare. Il Mediterraneo costituisce infatti la rotta migratoria più pericolosa al mondo: dal 2014 al 2024, l’ONG SOS Méditerranée ha recensito più di 28 mila vittime, dato che non tiene conto dei naufragi invisibili, ovvero quei naufragi di cui non si ha traccia, né memoria.
I rescuers: una vita a salvare vite
Alla domanda «a quante missioni di ricerca e soccorso hai partecipato», Jonathan Naní La Terra, SAR Team Leader, risponde sorridendo, guardando la nave «quante ne ha portate a termine Emergency?». L’equipaggio scherza dicendo che è nato sulla Life Support, insieme ai divani e ai salvagenti. In effetti, Naní La Terra ha fatto del search and rescue la sua vita, come è testimoniato dal tatuaggio sul suo braccio: due mani che si tengono, circondate da cime. «Quello che facciamo noi di Emergency è colmare un vuoto», dice il SAR Team Leader della Life Support. Le ONG come Emergency agiscono soprattutto nelle zone SAR (search and rescue, aree geografiche marittime all’interno delle quali un determinato Stato è responsabile del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso) delle acque internazionali, per far fronte all’insufficienza dei soccorsi portati avanti dalle guardie costiere e da Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Nel 2024 le organizzazioni non governative come Emergency hanno salvato il 18% di tutte le persone che sono state soccorse nel Mediterraneo.
Camille Auvergne, responsabile del ponte, è invece alla sua seconda missione con Emergency. Dopo dieci anni da assistente sociale in diversi paesi del mondo, ha preso una pausa e ha iniziato a viaggiare in mare. «Ad un certo punto ho semplicemente unito le mie due esperienze, quella sociale e quella marittima», dice Auvergne, seduta sul ponte della Life Support. «Ho sempre avuto in mente l’idea di lavorare nel Mediterraneo, sapendo cosa succede ogni giorno su questa rotta migratoria. L’anno scorso mi sono sentita pronta e sono entrata in Emergency».
Per Camille Auvergne, il suo lavoro è una diretta conseguenza dell’assenza di rotte migratorie sicure. Una denuncia fatta spesso dalle associazioni umanitarie e da diverse organizzazioni internazionali, che chiedono l’apertura di percorsi migratori legali.
«Dobbiamo costruire dei corridoi migratori sicuri, in un modo sociale e umanitario, invece di sparare ai confini», dice la responsabile del ponte. La sua idea è ripresa da un altro membro dello staff di Emergency, Alessandro Biffi. Già collaboratore di Emergency a Milano, Biffi si è imbarcato sulla Life Support per due missioni. Durante un turno di vedetta, sul ponte della nave, Biffi parla della sua esperienza a bordo. «Mi piace molto come lavorano le persone della Life Support perché sostanzialmente fanno un lavoro sperando di non doverlo mai più fare», dice alludendo alla speranza che le rotte non sicure e mortali del Mediterraneo possano, un giorno, avere fine.
L’ostilità della politica e dell’opinione pubblica
L’obbligo di assistenza in mare è sancito dal diritto internazionale, che è estremamente chiaro in materia: il comandante di una nave ha l’obbligo di portare soccorso a chiunque si trovi in stato di pericolo. È quindi tenuto a procedere con rapidità all’assistenza di persone che rischiano la vita in mare.
Nel momento in cui una ONG si trova vicina a un’imbarcazione in pericolo, questa è obbligata a portarle soccorso: un’operazione che è messa in pratica dal SAR Team, cioè il team di search and rescue, e assicurata dal team dell’accoglienza, composto dall’equipe medica e dai mediatori culturali.
«Una volta che abbiamo soccorso un’imbarcazione, ci rifacciamo alle autorità competenti, che ci assegnano un porto in cui sbarcare», spiega Jonathan Naní La Terra.
Secondo il diritto internazionale, il porto di sbarco deve essere il porto sicuro più vicino alla posizione del salvataggio.
Come “porto sicuro” si intende un porto in cui i sopravvissuti non si trovino esposti ad alcun rischio per le loro vite e in cui possano accedere ad alcuni beni e servizi fondamentali (cibo e acqua, rifugio e riparo, cure mediche) e in cui possano presentare ad esempio una richiesta di asilo. «Il concetto di porto sicuro è molto importante», continua il SAR Team Leader, «perché ci vieta di far sbarcare le persone migranti in zone non sicure come la Libia, dove i diritti umani non sono tutelati». In Libia, sono ormai numerose le documentazioni di continue e sistematiche violazioni dei diritti umani, soprattutto nei confronti delle persone che tentano di attraversare il Mediterraneo.
Il ruolo che la Libia ha nel Mediterraneo rientra in quello che viene chiamato il fenomeno di esternalizzazione delle frontiere, ovvero l’insieme di pratiche, in questo caso portate avanti dall’UE, messe in atto al di fuori di un territorio per cercare di arginare i flussi migratori e impedire l’ingresso delle persone migranti. Una pratica che Anabel Montes Mier definisce come “il trasferimento dei problemi lontani dall’Europa”, in questo caso in Libia, che “invece di salvare le persone naufragate in mare, le riporta nei luoghi da dove stanno fuggendo”. Numerosi sono i report e le inchieste pubblicate in questi anni che hanno dimostrato come l’Europa dia fondi alla Libia e addestri le cosiddette guardie costiere libiche, nonostante il Paese non sia considerato un porto sicuro per le persone migranti. Bisogna inoltre sottolineare che l’Unione Europea non ha un accordo ufficiale con la Libia, ma alcuni dei suoi Stati membri sì, tra cui l’Italia. «Anche se è l’Italia ad aver direttamente firmato questo accordo», dice Montes Mier, «l’Europa sta lasciando che questo accada, supportando il memorandum».
«Perché l’Europa continua a lavorare con la Libia anche se è consapevole delle pratiche inumane che questo Stato perpetra nei confronti delle persone migranti?”,
continua la capo missione. «Ogni persona che lavora nell’ambito dei salvataggi in mare si pone questa domanda. Credo che dovremmo porla ai diretti interessati. Unione Europea, questa è una domanda per voi: perché continuare a fare tutto ciò?»
L’esternalizzazione delle frontiere europee va di pari passo con un altro fenomeno: l’ostacolamento del lavoro delle ONG, che passa, per esempio, attraverso la pratica dell’assegnazione dei porti lontani, giustificata dal governo italiano con l’indisponibilità di posti e difficoltà logistiche nei porti del sud Italia. Nel 2024, per esempio, alla Life Support è stato assegnato tre volte il porto di Ravenna, due volte quello di Ancona, due volte quello di Livorno, poi una volta Civitavecchia, Ortona, Napoli, Vibo Valentia e Catania. «Questa prassi ormai consolidata del governo italiano ha costretto la Life Support a percorrere ben 630 miglia nautiche in più in media per ogni missione, impiegando oltre tre giorni di navigazione», si legge sul report di Emergency del 2025. Ulteriori giorni di navigazione nel Mediterraneo per raggiungere porti lontani significano un aumento delle spese sostenute da Emergency e un utilizzo della nave che non permette di compiere altri salvataggi.
È evidente come il decreto Piantedosi sia utilizzato dal governo italiano per ostacolare l’operato delle ONG. “Secondo il decreto Piantedosi, una nave che soccorre una barca in pericolo è tenuta a recarsi il più velocemente possibile verso il porto assegnato”, spiega Jonathan Naní La Terra. Nella pratica, quindi, il decreto impone, dopo una missione di SAR, di navigare senza indugio verso il porto assegnato, anche se i naufragi a bordo sono pochi, molti meno della capacità di accoglienza della nave. Famosa è stata per esempio la missione di ottobre 2024 della Humanity 1, quando la nave della ONG tedesca ha salvato un singolo migrante, che cercava di portare a termine la traversata da solo. Una volta a bordo, da Roma è arrivata l’assegnazione del porto: Empedocle, ossia tre giorni di navigazione per la nave, che non ha potuto fermarsi in area di operazione, ma è stata obbligata a riprendere subito il mare.
Dalla parte giusta?
«Se ci fosse una barricata, non potrei mai pensare di stare dall’altra parte dello schieramento», dice Alessandro Biffi, mentre con il binocolo guarda l’orizzonte in cerca di barche in pericolo. Il tema dell’immigrazione e della rotta del Mediterraneo Centrale continua a dividere e polarizzare l’opinione pubblica ormai da anni. È una divisione che ha percepito anche Camille Auvergne nella sua cerchia di familiari, amici e conoscenti. «La maggior parte delle persone del mio entourage sono molto fiere e supportano il mio lavoro», spiega, «ma tante altre non sono a loro agio e mi fanno commenti negativi. «Con loro cerco di non lottare, faccio solo una domanda:
«ci sono persone che muoiono in mare, cosa facciamo?», spiega la deck leader. «Il nostro lavoro consiste nel salvare vite. Fine della discussione. Le persone affogano e noi proviamo a salvarle».
Le parole di Camille suonano particolarmente cariche di senso nel momento in cui le pronuncia, dopo diverse ore trascorse a cercare corpi avvistati nella zona SAR libica, che le cosiddette guardie coste libiche hanno rifiutato di soccorrere.
L’attività della Life Support è criticata anche da una parte della politica e dell’opinione pubblica, che criminalizza l’operato delle ONG, denunciando un'alleanza con i trafficanti e gli scafisti. La criminalizzazione delle ONG, soprattutto da parte della politica, è un fenomeno in aumento, come è stato segnalato dal media monitoring di PICUM - ONG che mira a promuovere la giustizia sociale e il rispetto dei diritti umani dei migranti privi di documenti in Europa - , che nel suo ultimo report ha confermato una tendenza in crescita: nel 2024 almeno 142 persone hanno affrontato procedimenti penali o amministrativi per aver agito in solidarietà con i migranti nell’Unione Europea. Diversi processi sono stati aperti a riguardo, ma nessuno di essi è riuscito a dimostrare la collaborazione tra ONG e scafisti.
«Credo che sia molto conveniente per la politica dire che le ONG siano alleate dei trafficanti», dice Biffi. «Perché noi siamo qui a fare un lavoro che dovrebbero fare loro: le istituzioni, l’Europa e gli Stati che la compongono, ma che non fanno».
Alessandro riprende il concetto già espresso dalla capo missione precedentemente: «non siamo eroi, siamo solo qui per fare in modo che persone che arrivano da altri posti abbiano la possibilità di avere dei diritti”. Poi aggiunge: «Sai, mi piace molto la parola diritto in inglese: right. Perché right non significa solo diritto ma anche giusto. Secondo me è giusto che tutti abbiano gli stessi diritti ed è giusto quello che facciamo noi».