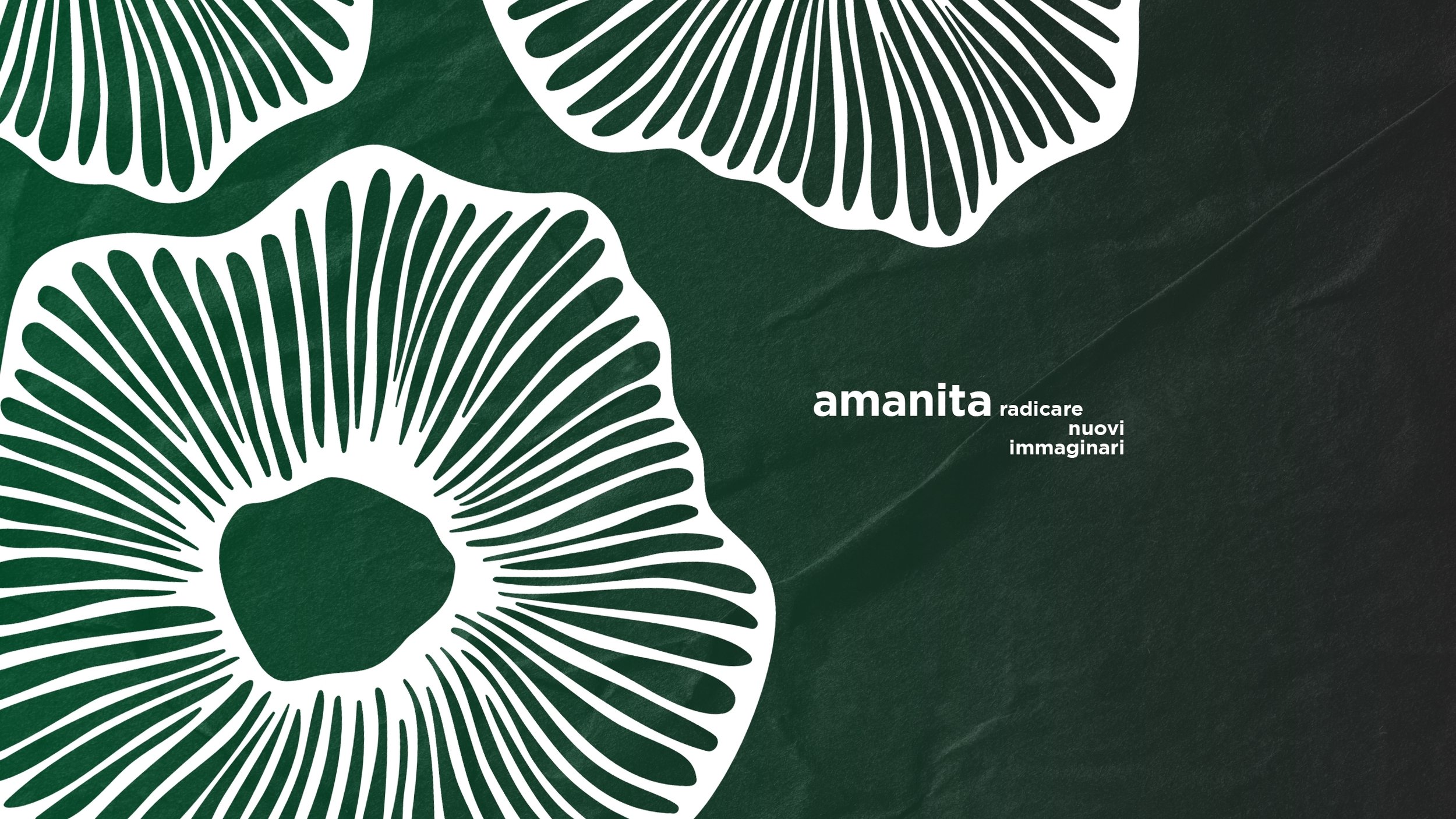Dalle banchine di Genova alla Palestina
‘Bloccare tutto’ per riscoprire il potere delle masse.
di Camilla Donzelli
A fine agosto, il porto di Genova è diventato l’epicentro di una mobilitazione che ha unito lavoratorǝ, attivistǝ e cittadinǝ sotto un unico slogan: “Blocchiamo tutto”.
Davanti a più di 40mila persone riunite sotto i colori della bandiera palestinese per salutare la partenza della Global Sumud Flotilla, il portuale Riccardo Rudino, membro del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (CALP), ha preso il microfono e scandito parole che avrebbero continuato a riecheggiare per giorni:
“Se per solo 20 minuti perdiamo il contatto con le nostre barche e con i nostri compagni, noi blocchiamo tutta l’Europa. Insieme al nostro sindacato USB, ai lavoratori portuali, e a tutta la città di Genova, da questa regione non esce più un chiodo. Lanceremo lo sciopero internazionale. Bloccheremo le strade, bloccheremo le scuole, bloccheremo tutto. Tutta questa merce, che è del popolo che sta dando al popolo, fino all’ultimo cartone, deve arrivare dove deve arrivare”.
Questa scena di fine estate non compare dal nulla. È una delle tappe di una lunga storia di auto-organizzazione che affonda le proprie radici nella città portuale, nel solco di una tradizione di lotta solidale e antimilitarismo. Per comprenderla, bisogna tornare alla genesi del CALP:
un collettivo che è stato capace di riannodare memoria operaia, pratica sindacale e internazionalismo.
Il CALP di Genova nasce a fine 2011, subito dopo la grande manifestazione organizzata a Roma su spinta del movimento degli Indignados. José Nivoi, portavoce del collettivo, spiega a Miccia Mag che il gruppo raccoglie il testimone dei consigli di fabbrica presenti in città negli anni ‘60 e ‘70, e si è inizialmente formato come spinta interna alla CGIL, in un periodo in cui il sindacato aveva già perso il carattere di rappresentanza dellǝ lavoratorǝ e prendeva sempre più una piega meramente concertativa.
“Il CALP nasce soprattutto con la funzione di mettere in dialogo costante i portuali”, spiega Nivoi. “Ci faceva un po’ strano il fatto che all’interno del sindacato non si potesse parlare di questioni politiche, che poi avevano delle ricadute anche sui lavoratori. Partecipare alla chiusura di sedi di CasaPound e Forza Nuova, dove la CGIL sostanzialmente non si posizionava, ha fatto sì che si creassero le basi per una sorta di boicottaggio interno”.
Quando l’approccio militante del collettivo si scontra con l’immobilismo della CGIL, il gruppo decide di uscire in blocco. Il CALP passa così sotto l’ala dell’Unione Sindacale di Base, continuando a condurre le proprie attività con uno spirito spiccatamente antifascista e anticapitalista.
Dalle banchine alla rete: geografie di un movimento in espansione
Quella dello sciopero è una strategia che il CALP ha adottato sin dall’inizio. Nel 2019, il collettivo decide di incrociare le braccia in banchina, riuscendo a bloccare le operazioni di carico di alcuni container pieni di armamenti destinati all’impiego nella guerra in Yemen.
Ne segue una maxioperazione di polizia, con ripetute perquisizioni e l’apertura di un fascicolo per associazione a delinquere, che verrà chiuso solo nel 2023. Questa reazione violenta da parte delle autorità fornisce ai membri del CALP la conferma di essere sulla strada giusta. “Per due anni, queste accuse hanno permesso alla polizia di sorvegliarci e perquisirci a piacimento”, racconta Nivoi. “Volevano spaventarci e scoraggiarci, ma noi ci siamo detti: se fanno una cosa del genere è proprio perché stiamo toccando il nervo scoperto”.
Nelle parole di José Nivoi si cela una verità cruciale. La risposta repressiva dello Stato dimostra infatti che quelle azioni vengono percepite come una minaccia al funzionamento del sistema stesso.
Significa che si è andato a toccare un nodo che non è solo etico e simbolico, ma anche e soprattutto economico: si sta intralciando la logistica che alimenta i profitti.
Nel libro “Capitalismo cannibale”, la studiosa femminista Nancy Fraser spiega che c’è un legame di strettissima dipendenza fra l’espropriazione delle popolazioni indigene delle cosiddette “periferie globali” e lo sfruttamento della classe lavoratrice nelle metropoli. In un sistema economico che si basa sull’espansione illimitata, chi detiene il potere finanziario ha un forte interesse nel ridurre al minimo i costi di produzione. Assoggettare intere popolazioni e territori lo rende possibile: l’espropriazione fornisce, da un lato, input economici pressoché gratuiti come energia e materie prime; dall’altro, consente di immettere nel mercato beni di prima necessità a basso costo, come cibo e vestiario, che permettono di mantenere bassi anche i salari. La confisca di risorse e capacità a popolazioni assoggettate rende così più proficuo lo sfruttamento dellǝ lavoratorǝ “liberǝ”.
Questa divisione codipendente tra espropriatǝ e sfruttatǝ coincide con la “linea del colore” globale, e porta con sé ingiustizie strutturali quali l’oppressione razziale, l’imperialismo e il genocidio.
Capire questo meccanismo significa per prima cosa essere coscienti di come l’architettura capitalista ci renda tuttǝ interconnessǝ, e quindi corresponsabili.
Ma significa anche riconoscere che interrompere la catena delle forniture militari non è un semplice gesto morale isolato, ma un attacco diretto agli equilibri di guerra, che consentono a questo sistema oppressivo e diseguale di prosperare e riprodursi.
Se la macchina del profitto si regge su corridoi logistici e relazioni transnazionali, la forma di sabotaggio più efficace deve costruire leve materiali che vadano nella stessa direzione: scioperi coordinati, blocchi logistici mirati e reti di solidarietà che rendano difficile la normalità dei flussi di guerra. Questo, i portuali lo hanno capito molto bene.
Come ricorda Nivoi, le prime mobilitazioni del CALP a supporto della popolazione palestinese risalgono al 2021, con il blocco di un carico di missili attuato grazie al coordinamento con i porti di Livorno e Napoli. “Ma le adesioni sulla questione palestinese nel mondo del lavoro sono sempre state un crescendo”, aggiunge.
Non a caso, l’appello urgente lanciato dalla rete di sindacati palestinesi Workers in Palestine a ottobre 2023 ha risuonato forte e chiaro nei porti dell’Europa continentale e del bacino mediterraneo.
A dicembre 2024, il sindacato dei portuali svedesi ha votato per il boicottaggio dei carichi militari da e per Israele. Ne sono seguite azioni di blocco che, nell’arco dei mesi successivi, hanno coinvolto sindacati e collettivi in Marocco, Francia, Italia, Spagna e Grecia.
Nivoi spiega che le azioni che si sono succedute non sono il frutto di iniziative individuali, né tantomeno il loro successo è da considerarsi casuale. “Da un anno e mezzo stiamo cercando di trovare la formula per mettere in contatto i portuali di varie organizzazioni”, racconta. “A febbraio, abbiamo tenuto una prima riunione ad Atene, in cui erano presenti greci, francesi, tedeschi, turchi, ciprioti e marocchini. Quello che vogliamo fare è creare un dialogo per identificare le dinamiche ricorrenti all'interno dei vari porti del Mediterraneo: attacco al mondo del lavoro, abbassamento dei salari, precarizzazione, svendita al settore privato, e così via.
È una piattaforma che parte dal lavoro per arrivare alla questione guerra, e soprattutto al sostegno incondizionato alla popolazione palestinese.
Le varie comunicazioni che ci sono state tra francesi, greci e noi per bloccare il carico di armi fra giugno e luglio sono state il primo embrione di questo coordinamento internazionale”.
L’internazionalismo non è un concetto astratto
L’internazionalismo nasce dal riconoscimento materiale che chi lavora è, da sempre, la prima vittima delle guerre che contribuisce a rendere possibili. Come ricorda José Nivoi,
“i cannoni che oggi costruisco io e che sparano al mio vicino di casa, domani potrebbero tranquillamente essere quelli che spareranno a me”.
In altre parole, la guerra non è solo un fenomeno esterno: è anche una guerra interna, condotta contro le classi popolari attraverso la precarietà, la povertà e la repressione.
Per i portuali di Genova, opporsi ai traffici d’armi non è un gesto simbolico, ma un atto di responsabilità collettiva. “Il fatto che io vada a lavorare e contribuisca al genocidio mi rende complice”, afferma Nivoi. Non si tratta di un moto di coscienza individuale, ma di una consapevolezza politica condivisa, che impedisce di separare il proprio lavoro dagli effetti che produce. È qui che l’internazionalismo torna al suo significato originario:
non solidarietà a distanza, ma pratica concreta di non-collaborazione con un sistema di guerra che si regge sullo sfruttamento del lavoro vivo.
La guerra, del resto, non si limita a devastare i territori occupati: ritorna nelle nostre case sotto forma di inflazione, precarietà, tagli al welfare. Come spiega Nivoi, mentre “il neoliberismo in crisi utilizza la guerra per riempire i propri granai, la spesa pubblica si sposta dal comparto civile a quello militare”. Ciò significa che
ogni arma prodotta si traduce in meno fondi per sanità, istruzione, pensioni, redditi.
La guerra è quindi un problema diretto del mondo del lavoro: un dispositivo economico che trasferisce ricchezza dal basso verso l’alto, travestito da emergenza geopolitica.
È da questa comprensione che nasce la possibilità di un fronte comune. La connessione tra guerra e impoverimento non riguarda solo chi lavora nei porti, ma coinvolge anche insegnanti, studentə, impiegatə pubblicə, precariə. “Anche loro cominciano a rendersi conto che in questa fase tutto comincia a costare un po’ troppo”, afferma Nivoi. “Dall’aumento dei mutui alla pasta che ti costa di più, è tutto frutto del fatto che sei in guerra”.
L’internazionalismo smette così di essere un orizzonte lontano e diventa una pratica quotidiana: un modo per ricostruire solidarietà materiale tra chi subisce oppressione, sfruttamento e impoverimento, da Gaza ai porti europei.
Il potere delle masse
A questo punto, rimane però da affrontare il nodo pratico: come fermare la macchina della guerra?
Il sistema in cui viviamo è pervaso dalla logica della pacificazione democratica. Non importa quale sia l’orientamento politico del governo di turno: in maniera più o meno intensa, l’azione politica diretta è fortemente scoraggiata, se non apertamente contrastata.
La forma massima di partecipazione concessa è l’esercizio del voto, attraverso il quale lǝ cittadinǝ delegano la responsabilità decisionale a istituzioni e partiti. Il conflitto viene in tal modo depotenziato, mediato e delocalizzato:
dalle strade alle discussioni parlamentari, in cui ogni piccolo passo in avanti non è altro che una mera concessione calata dall’alto.
A ciò si aggiunge una struttura sociale sfilacciata, in cui anche la tensione verso il cambiamento viene ridotta a responsabilità e sforzo individuale. La collettività scompare dal discorso pubblico, sostituita dall’idea che il progresso sia il risultato dell’azione di poche figure eccezionali.
La santificazione del “leader eroico”, trasformato in simbolo isolato e inavvicinabile, è parte di questo processo di depotenziamento.
Angela Davis, in “La libertà è una lotta costante”, smonta questa narrazione. Ricorda che né Nelson Mandela né Martin Luther King agirono come leader solitari:
le loro battaglie contro l’apartheid e la segregazione razziale furono rese possibili da reti capillari di militanti, lavoratorǝ, studentǝ e sindacati. Il mito del leader carismatico serve al potere per mistificare la forza collettiva che rende possibile ogni trasformazione reale.
È una strategia di disinnesco, che concentra l’attenzione sull’individuo per cancellare la trama di relazioni e di pratiche che lo sostiene.
Il lavorio quotidiano e instancabile di collettivi come il CALP sta finalmente riportando alla luce proprio questa dimensione collettiva insabbiata. Attraverso presidi, assemblee e spazi di dialogo reale, il movimento nato nelle banchine sta riaccendendo la scintilla della partecipazione politica diretta. Nivoi ricorda una delle assemblee organizzate in estate a Genova per discutere la trasformazione del porto in infrastruttura militare europea. Per la prima volta dopo anni, racconta, “c’era anche tanta gente comune, con un sentimento di sinistra”.
Quel “blocchiamo tutto” gridato da Riccardo Rudino non è quindi una chiamata episodica, ma il segno tangibile di un percorso di ricomposizione politica dal basso.
È l’esito di un lavoro collettivo che ha restituito alle persone la coscienza del proprio potere di incidere, di fermare la produzione e di opporsi alla guerra non con gli appelli, ma con la materialità del rifiuto.
È in questa presa di parola collettiva che affonda le radici lo sciopero generale del 22 settembre: un momento in cui la coscienza si è fatta azione, e l’azione ha mostrato la forza reale delle masse organizzate.
Le immagini dellǝ automobilistǝ che, incappando nel corteo che occupa le strade di Roma, suonano i clacson per unirsi alla protesta rimarranno un manifesto indelebile di cosa abbia significato farsi marea. Sono immagini che non appartengono solo a un giorno di protesta, ma a un processo che deve continuare a espandersi.
Come scrive Rodrigo Nunes nel libro “Né verticale né orizzontale”, i movimenti non sono mai un blocco monolitico, ma un ecosistema in cui forme diverse di azione, organizzazione e solidarietà si intrecciano e si rigenerano a vicenda. Pensare la lotta in questi termini – come un’ecologia di relazioni in movimento – significa riconoscere che nessuna spinta collettiva si esaurisce davvero: cambia forma, attraversa tempi e soggettività, trova nuove vie per tornare a esistere.
“Blocchiamo tutto” non è quindi un punto d’arrivo, ma un passaggio di testimone. Sta a tuttǝ noi, adesso, tenere vivo ciò che si è rimesso in moto.