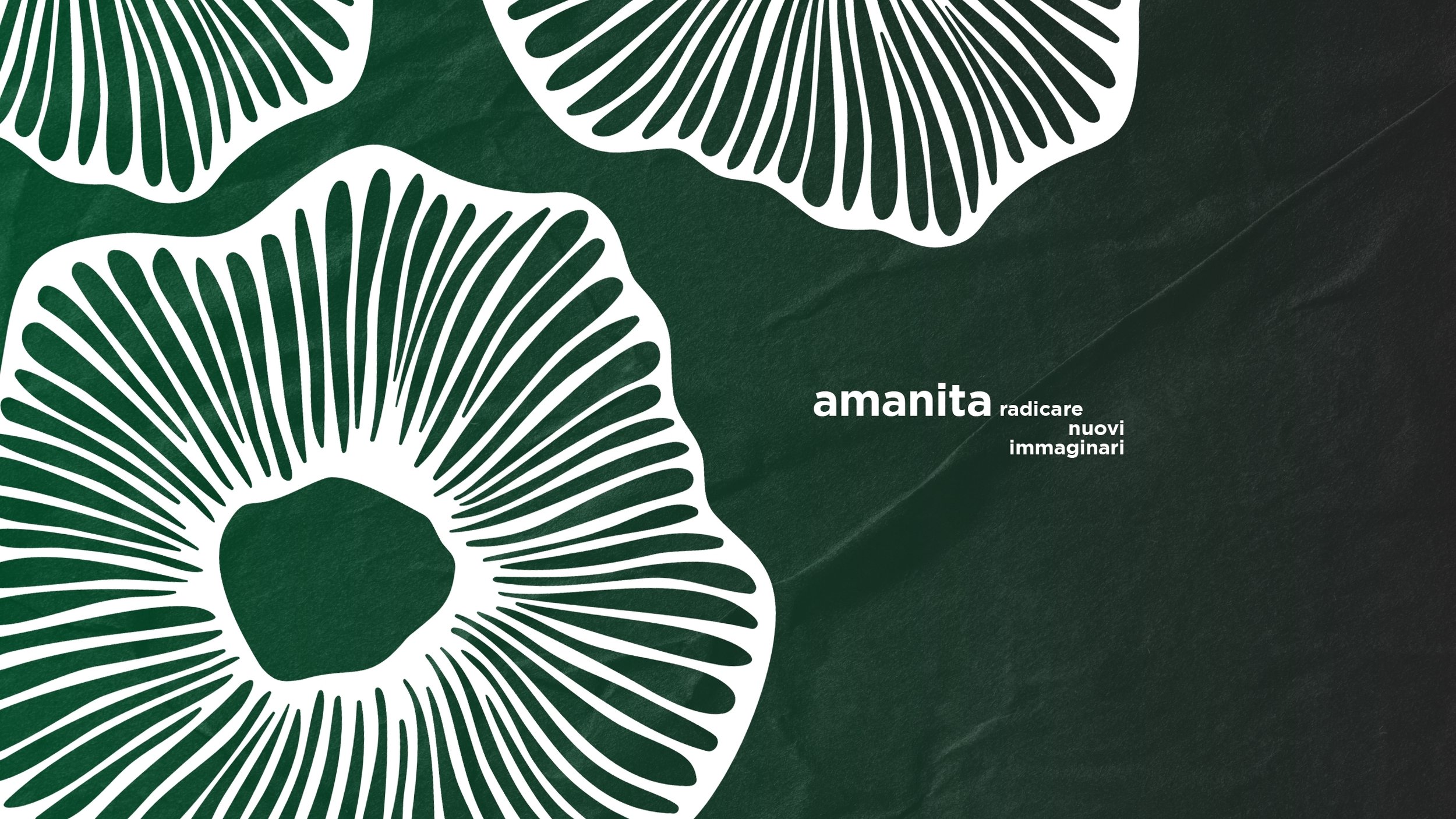Abolizione del carcere
È possibile immaginare un sistema senza prigioni?
di Camilla Ponti
Nel libro “Grammatica della fantasia”, lo scrittore Gianni Rodari scriveva: “Cadono tutte le sbarre di tutte le prigioni del mondo. Escono tutti. Anche i ladri? Si, anche i ladri. È la prigione che produce i ladri. Finita la prigione, finiti i ladri”. Una riflessione ancora attuale ma del tutto scomparsa dal dibattito pubblico. Perché non riusciamo ad immaginare l’abolizione del carcere?
La naturalizzazione dell’istituzione penitenziaria è profondamente radicata all’interno del tessuto sociale occidentale. L’utilizzo nel sistema giudiziario della pena detentiva si è affermato con l’ascesa dello Stato moderno, per poi consolidarsi con l’espandersi dell’attuale sistema produttivo capitalista, dopo la seconda rivoluzione industriale. Prima del XVIII secolo, l'infrazione di una legge era punita tramite l’infliggere sofferenza corporea, spesso all’interno di uno spazio pubblico - le piazze -, e le celle erano soltanto luoghi di attesa della pena.
A seguito delle due rivoluzioni industriali, il consolidamento di un potere sempre più centralizzato e non dinastico è andato di pari passo con la necessità di trovare una soluzione al reato, congrua al sistema capitalista. A partire da riflessioni di matrice illuminista, tra cui quelle di Jeremy Bentham, si diffuse il pensiero che una punizione fisica non fosse più sufficiente, e che fosse imprescindibile aggiungere alla pena una variabile che permettesse di disciplinare anche la sfera psichica e, quindi, la totalità della persona. Se in passato il reato veniva vissuto come danno diretto a persone singole - re, monarchi, imperatori - e come affronto alle gerarchie sociali, l’astrazione del potere insita nel concetto di Stato ha diffuso l’idea che l’infrazione di una legge rechi un’offesa collettiva da riparare tramite l’allontanamento e la sorveglianza a lungo termine della singola persona, altresì detti rieducazione.
Le reali funzioni dell’istituzione penitenziaria sono evidenti nel concetto di prison industrial complex, o complesso carcerario-industriale, coniato da attivistɜ e militanti come Angela Davis intorno al 1997, nello scenario delle lotte antirazziste e per l’abolizione del carcere statunitensi.
Il costrutto di complesso carcerario-industriale indica l’intersezione tra gli interessi economici e politici alla base del sistema delle carceri, della repressione e della sorveglianza.
Partendo dallo scenario statunitense, all’interno del quale solitamente le prigioni sono gestite da enti privati che ricevono fondi pubblici - e quindi producono profitto - per ogni persona detenuta, questa teorizzazione mette in luce come
il carcere sia prima di tutto una questione economica:
aziende vincono appalti per costruire e gestire le infrastrutture, altre forniscono i servizi e i corpi delle persone recluse vengono monetizzati tramite lo sfruttamento di manodopera gratuita/a basso costo. Dunque, emerge come il carcere sia a tutti gli effetti un mercato e, come ogni mercato, necessiti di essere sempre in continua crescita. In questa dimensione si inseriscono quindi le politiche repressive, sostenute anche dai mass media, che hanno il compito di mantenere alto il numero delle persone detenute promuovendo profilazione razziale, criminalizzazione della libertà di movimento, della povertà e della sofferenza psichiatrica, inasprimento delle pene per reati minori. L’idea liberal-democratica che la legge sia uguale per tuttɜ crolla completamente davanti all’evidenza di come l’istituzione carceraria affondi le sue fondamenta nel razzismo e classismo istituzionali.
Secondo uno studio del 2025 portato avanti dal The Sentencing Project, un’organizzazione no profit statunitense che si occupa di giustizia detentiva, negli USA una persona nera ha il quintuplo delle possibilità di essere incarcerata rispetto a una bianca.
I dati 2025 del Ministero della Giustizia italiano rispetto alla popolazione detenuta mostrano come la maggior parte delle persone recluse sia povera, senza un privilegio abitativo, con sofferenza psichiatrica - in particolare tossicodipendenza -, di origine straniera, senza i documenti in regola, migrante, con un basso livello d’istruzione o disoccupata.
Nello specifico, riferendosi alla variabile dell’origine, al 31 gennaio 2025 le persone detenute adulte di origine straniera erano 19.622, pari al 31,7% del totale della popolazione detenuta. Secondo le statistiche dell’Associazione Antigone a fine febbraio 2024 nelle carceri minorili italiane erano presenti 523 detenuti; il 51% era rappresentato da minori di origine straniera.
Questi numeri sono sempre stati strumentalizzati dalle istituzioni e dai mass media per fomentare narrazioni razziste e criminalizzanti nei confronti delle persone razzializzate.
In realtà, essi dimostrano semplicemente come in Italia una persona di origini straniere abbia più probabilità di essere condannata ad una pena detentiva.
Benché non ci siano ancora dati ufficiali sulla profilazione razziale portata avanti dalle Forze dell’Ordine, una persona razzializzata ha molte pià probabilità di essere fermata, come segnala il rapporto Essere nerɜ nell’UE. Nel capitolo dedicato ai fermi di polizia in Italia, il 48 per cento dellɜ intervistatɜ ritiene che il suo ultimo fermo sia stato dettato da un pregiudizio razziale.
Emerge quindi come la funzione riabilitativa della pena detentiva serva in realtà a nascondere la macchina oppressiva e repressiva dell’istituzione carceraria, sostenuta, dall’interno e dall’esterno, dalla brutalità quotidiana delle Forze dell'Ordine. Le stesse statistiche - italiane - rispetto alla recidiva post detenzione evidenziano come l’effetto rieducativo delle carceri sia irrisorio. Inoltre, concentrandosi su crimini violenti - femminicidio, omicidio, reati sessuali - è evidente come, da un punto di vista psicologico, sociologico ed educativo, un sistema basato sull’esercizio verticale del potere, sulla punizione, sulla mortificazione del corpo e della psiche, sull’umiliazione e la coercizione non possa decostruire e ristrutturare comportamenti abusanti e prevaricanti, ma solo accentuarli maggiormente.
L’apparato della giustizia tradizionale colpevolizza la persona singola rispetto alle proprie condizioni di marginalizzazione e, nel mentre, sposta l’attenzione collettiva da tutte quelle condizioni strutturali che permettono il mantenimento dei divari socio/politico/economici tra le varie fasce della popolazione.
Se lɜ ultimɜ rimangono ultimɜ, lɜ primɜ vedranno tutelata all’infinito la loro posizione di privilegio.
È a partire da queste consapevolezze che nasce l’odierno movimento abolizionista, che immagina l’abolizione del carcere. L’abolizionismo non è un movimento unitario, ma un insieme concreto di diversi approcci politici e sociali che convergono nella convinzione che
la cosiddetta criminalità non possa essere presa in carico tramite un approccio punitivo e strutturalmente violento, ma mediante una ristrutturazione - economica, politica, ma anche emotiva e culturale - volta alla dissoluzione delle condizioni che mantengono vivi i divari sociali e alla riparazione collettiva del danno.
Le varie teorizzazioni per l’abolizione del carcere implicano e prevedono una trasformazione radicale della maniera in cui affrontiamo i conflitti, partendo dalla necessità di investire prima di ogni altra cosa nella tutela e nella cura di tuttɜ. Le origini del movimento occidentale per l’abolizione del carcere vanno fatte risalire alle lotte per l’abolizione della schiavitù delle persone deportate dal continente Africano venutesi a creare in Europa e negli Stati Uniti fra la fine del ‘700 e tutto il corso dell’800. Sulla carta, la fine della Guerra di Secessione nel 1865 pose termine anche alla schiavitù negli Stati Uniti. Tuttavia, studiosɜ, attivistɜ e militanti come Michelle Alexander e Angela Davis fecero emergere come la creazione del sistema carcerario-industriale non fu altro che il proseguimento, sotto copertura, del precedente sistema schiavista e di segregazione razziale coloniale.
Ed è a partire dalle lotte per l’abolizione del carcere di comunità razzializzate, indigene, marginalizzate e oppresse che sono nate alternative alla cosiddetta giustizia tradizionale, tra cui la giustizia trasformativa.
Secondo Giusi Palomba, autrice del libro “La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere” (minimum fax, 2023) e facilitatrice di gruppi, intervistata da Voice Over Foundation: “Quando parliamo di giustizia trasformativa ci riferiamo a pratiche molto concrete. La definizione emerge tra gli anni ‘90 e i primi anni 2000 negli Stati Uniti, quando le comunità di donne e persone nere, migranti, trans, queer, povere e working class hanno dato un nome alle strategie di autorganizzazione per contrastare non soltanto la violenza interpersonale, ma anche quella esercitata dalle istituzioni e dalla polizia sulle comunità.
Parlare di giustizia trasformativa significa prima di tutto creare nuove infrastrutture e immaginare nuove figure, senza uniforme, capaci di intervenire per risolvere conflitti o violenze e di esplorare scenari alternativi rispetto a quelli della giustizia tradizionale, magari più efficaci a lungo termine.
Le pratiche di accountability comunitaria vanno controcorrente rispetto ad una società che davanti a un conflitto o una violenza non prevede altro che criminalizzazione o castigo. Senza dubbio, il bisogno di punire esiste ma a volte può essere trasformato in altro, partendo da una elaborazione collettiva del vissuto per capirne insieme le origini, il funzionamento e l’utilità. Spesso, il desiderio di vendetta emerge come conseguenza del dover gestire in solitudine il trauma di vivere in una società oppressiva. I governi, in particolare quelli di estrema destra ma non solo, strumentalizzano i sentimenti di odio e vendetta, in quanto permettono di aumentare la criminalizzazione e la repressione in ogni ambito della società. Abbiamo visto ciò che è successo a seguito dello stupro di Caivano. La rabbia e l’indignazione collettive sono state utilizzate soltanto per restringere drasticamente gli spazi della giustizia minorile.”
Alla base delle diverse pratiche della giustizia trasformativa risiede l’idea che il reato, violento e non violento, non derivi da specifiche caratteristiche o atteggiamenti individuali, ma da condizioni strutturali economiche, sociali così come educative.
Di conseguenza, la presa in carico del reato non può consistere in una punizione, in un isolamento e in una creazione di uno spazio che perpetui le stesse dinamiche violente che l’hanno generato. Dunque, la giustizia trasformativa si basa sulla convinzione che solo una radicale trasformazione delle condizioni sociali - che permettano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di tuttɜ - delle dinamiche relazionali e delle basi socio-educative comuni possano realmente rispondere al reato e, nel tempo, risolverlo.
Sempre secondo Giusi Palomba: “È fondamentale ancorare la giustizia trasformativa alle sue genealogie. Sono convinta che uno dei tanti motivi per cui in Italia si parli così poco di giustizia trasformativa, o in generale di figure e infrastrutture comunitarie, derivi dalla difficoltà di riconoscere la violenza che interessa larghe fasce della società, le più criminalizzate e marginalizzate, di lavorare su razzismo e decolonialità, e di ragionare in genere sulle relazioni di potere, a livello interpersonale e sistemico. La giustizia trasformativa nasce in seno ad una critica molto vasta nei confronti delle strutture punitive, e si organizza intorno a domande come "Nel concreto, chi viene incarceratə? Chi viene criminalizzatə? Chi viene isolatə, marginalizzatə?” Una tensione che porta il conflitto nelle istituzioni, mentre si lavora sulla cura comunitaria.
Viviamo in una società che, come detto prima, ci ha educatɜ a normalizzare la punizione e la violenza.
Quindi, il rischio di scivolare continuamente in questa deriva autoritaria esiste anche nelle relazioni interpersonali e comunitarie”
Parlare di complesso carcerario-industriale significa quindi denunciare e rifiutare un sistema strutturale che criminalizza la marginalizzazione e monetizza sulla sofferenza, che crea solitudine, abbandono, individualismo e frantumazione, che abusa indisturbato e che protegge il privilegio di pochissimɜ sulla pelle e sulla libertà di tuttɜ lɜ altrɜ. Significa opporsi al perpetrare violenze di stampo coloniale, che mirano alla soppressione della totalità dell’essere umano. Significa sottrarsi all’idea di una società che colpevolizza la persona singola mentre la schiaccia, togliendole ogni possibilità di reale autodeterminazione.
Al contrario, diffondere pratiche di giustizia trasformativa abolizionista vuol dire immaginare l’abolizione del carcere e al tempo stesso scenari futuri alternativi; vuol dire, per esempio, pensare a cerchi di dialogo tra persone colpite e autorɜ del danno, che promuovano la responsabilizzazione, la consapevolezza, l’introspezione, l’ascolto empatico, la tutela reciproca; oppure, creare gruppi di supporto e condivisione emotiva rispetto all’elaborazione delle esperienze di violenza sistemica o dare spazio a momenti educativi transfemministi orientati alla costruzione di pratiche relazionali basate sul consenso, sul rispetto, sull'accettazione del confini e sull’espressione di sè. Diffondere pratiche di giustizia trasformativa vuol dire preservare il valore di una rabbia sana, potente e vitalizzante, che mira ad un cambiamento globale e irreversibile. Vuol dire resistere ad un potere che ci vuole divisɜ, lontanɜ e vuotɜ.
Se la giustizia non è uguale per tuttɜ, non è altro che oppressione ben nascosta. E, come disse lo scrittore e poeta tedesco Bertolt Brecht: “Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere”.