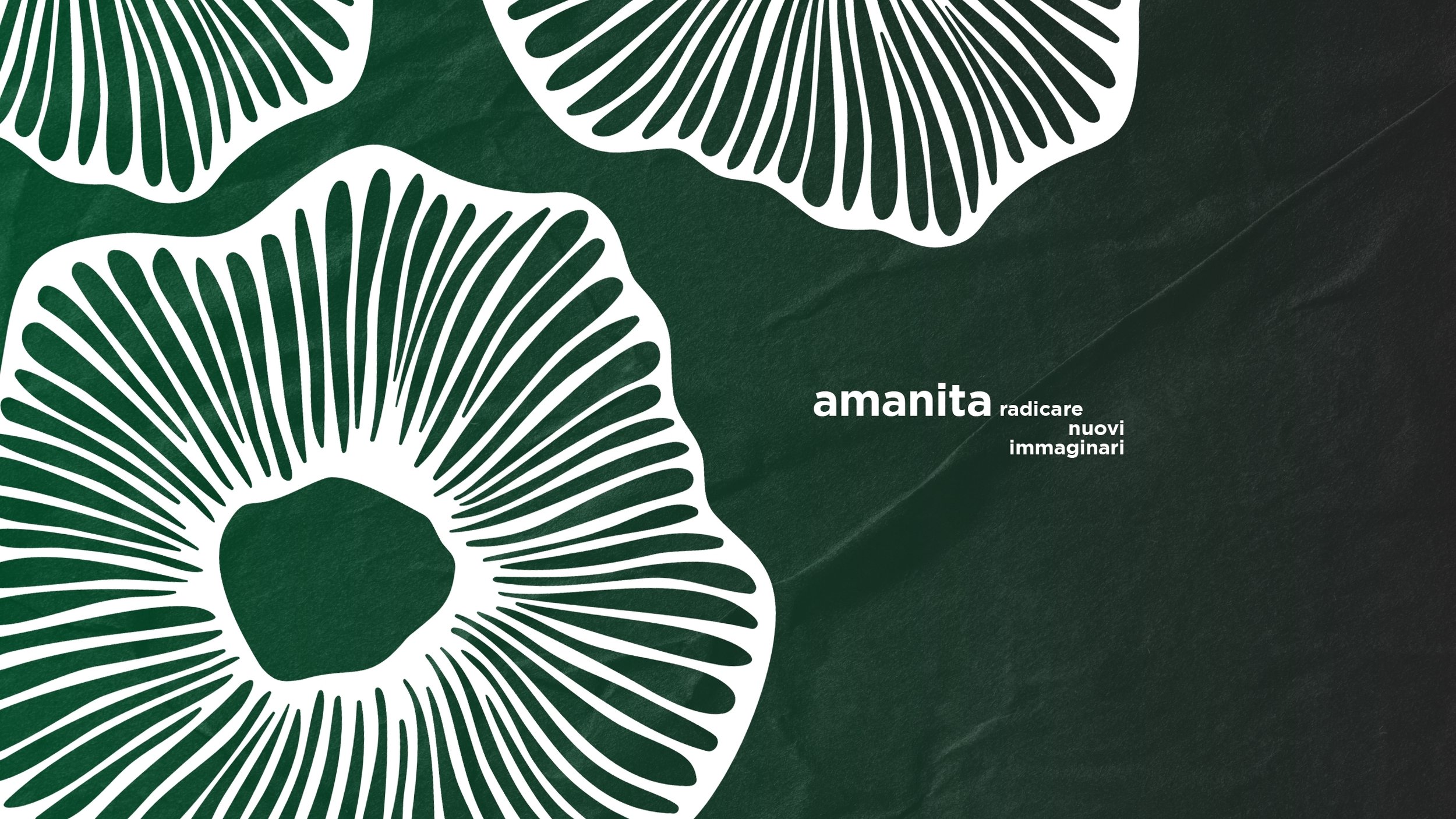L’insurrezione dei vivi
Costruire dissenso collettivo per rispondere alla strategia del terrore e all’isolamento sociale.
di Martina Maccianti
Viviamo tempi in cui la paura è utilizzata come forma di governo che disciplina gesti, parole, corpi. Si manifesta come un riflesso introiettato quando ci chiediamo se valga la pena esporsi, se convenga parlare, se dire “noi” sia ancora possibile senza pagare un prezzo. È una paura ordinata che si confonde con la ragionevolezza e che, proprio per questo, diventa più efficace di qualsiasi minaccia diretta. Ci troviamo dentro una strategia precisa di costruzione sistematica dell’intimidazione. È un sistema che agisce sulla percezione e che quindi non punta solo a reprimere, ma a modellare di netto la sensibilità collettiva. Una strategia che attraversa la politica, i media, la vita quotidiana, e che si fonda sulla gestione delle emozioni.
La destra ne è oggi l’interprete più consapevole e centrale, perché non governa solo con le leggi o con la forza, lo fa anche attraverso la manipolazione.
Rende la paura un linguaggio condiviso, una lente attraverso cui leggere il mondo. Ci insegna a diffidare, a sospettare, a ritrarci. Ci convince che l’altro è un pericolo, che la complessità è una minaccia, che la solidarietà è un rischio.
E questo non è un fenomeno isolato, né un’invenzione recente. La storia delle società disciplinari (ovvero quelle istituzioni, analizzate da Foucault, come la prigione, la scuola, la fabbrica o l’esercito, in cui l’individuo viene osservato, inquadrato e reso funzionale secondo la logica della produttività), lo dimostra, perché il potere non ha mai avuto bisogno solo della violenza, piuttosto della paura di subirla. Dalla paura del nemico interno durante la Guerra fredda, a quella del migrante, del povero, del diverso nel presente, la logica è la stessa:
individuare un corpo da temere per consolidare l’ordine.
La paura è la materia prima del consenso autoritario,
la valuta emotiva con cui si compra obbedienza.
La vediamo nei quartieri dove la solidarietà viene scambiata per disordine, nelle scuole e nelle università dove la presenza critica viene trattata come minaccia, nelle piazze dove la sorveglianza è diventata, insieme alla violenza, lo strumento di gestione del dissenso. Ogni spazio pubblico che si organizza è percepito come un’anomalia da contenere o una provocazione da punire.
È in questo modo che il potere riesce a ribaltare le responsabilità e le narrazioni trasformando chi resiste in colpevole e chi esercita violenza come difensore dell’ordine. È in questo spettro che la paura, così costruita, non serve solo a reprimere, serve a isolare,
a far sì che ogni atto di dissenso sembri un gesto solitario e non una pratica condivisa, così da mettere in atto un isolamento tangibile che è la forma più perfetta di obbedienza implicita.
Allora la nostra risposta non può che essere collettiva;
non per qualche forma di eroismo, per necessità. Resistere alla strategia del terrore non significa soltanto reagire, significa non smettere di costruire legami, anche quando tutto intorno spinge verso la frammentazione; non permettere che la paura diventi l’unico linguaggio possibile. Dobbiamo comprendere che la nostra forza sta nella capacità di attraversare il timore come fronte unito.
La questione quindi adesso è come trasformare quella paura in movimento, in rabbia organizzata, in solidarietà.
La strategia del terrore non si manifesta più soltanto con una brutalità evidente, si insinua saturando il discorso, ridicolizzando - come abbiamo visto con il video di Trump in risposta alle manifestazioni No Kings -, delegittimando, rendendo ogni gesto, ogni parola, ogni presenza potenzialmente sospetta (un esempio minore ma esplicativo è il modo in cui Giorgia Meloni, presidente del consiglio, definisce uno sciopero nazionale un escamotage per poter fare un “weekend lungo”). È una guerra sottile, che scava dentro le abitudini, nei piccoli spostamenti, nelle decisioni quotidiane su chi incontrare, cosa dire, come muoversi nello spazio pubblico e digitale. Non è un attacco diretto al corpo, è un’intrusione costante nella percezione che tenta di segnare i confini del possibile e ridurre il campo dell’immaginabile.
È una guerra silenziosa ma estremamente reale, e imparare a riconoscerla serve a costruire lucidità collettiva che sia una percezione condivisa del rischio:
così facendo la paura smette di disciplinare e diventa conoscenza. Leggere il potere significa non subirlo e finalmente vedere la mappa invisibile dei condizionamenti e dei limiti imposti, e capire come muoversi dentro e contro di essi.
Occorre creare infrastrutture di continuità, spazi di elaborazione che vivano nel ritmo delle relazioni, che non siano legati solo all’emergenza o all’urgenza dei momenti di crisi.
Questa continuità si manifesta nelle biblioteche aperte, nei centri sociali che resistono alla precarietà degli spazi, nei gruppi di studio che persistono nonostante le difficoltà materiali. Ogni collettivo che riesce a consolidare routine di confronto e di elaborazione sottrae terreno alla strategia del terrore, rendendo inefficace la logica della frammentazione e dell’isolamento. In tempi di precarietà, la stabilità stessa diventa già una forma di resistenza, una barriera invisibile contro chi tenta di spezzare i legami e di confinare la vita dentro spazi controllabili. Queste cose sono più facili da scrivere che da instaurare in mezzo al tenere in piedi la propria vita, certo, ma dobbiamo capire che senza queste cose la nostra vita personale non potrà che essere più precaria e isolata.
La destra conosce bene il potere della paura, per questo tenta di colonizzare l’immaginario, ridurre le possibilità e i futuri, convincere che non esista alternativa. Dobbiamo però avere chiaro che la libertà non nasce dalle leggi o dai decreti, nasce dalla capacità di immaginare e di pensare mondi diversi che ancora non ci sono ma che possiamo iniziare a costruire.
Qui sta il nostro vantaggio. Nel saper proteggere l’immaginazione e farla diventare un atto politico, un bene comune da difendere contro chi vuole imprigionarla.
Immaginare mondi diversi non significa solo pensare al futuro in astratto, significa sperimentare pratiche già oggi, prototipare forme di vita alternative. Un esempio significativo di questa tensione politica lo troviamo nel Comitato Invisibile, collettivo anonimo nato in Francia nel contesto delle rivolte delle banlieue del 2005. In Italia i principali testi del Comitato sono stati raccolti da NOT/Nero nel 2019 in un volume unico, L’insurrezione che viene, Ai nostri amici e Adesso, che ha saputo articolare una delle critiche più radicali alla società contemporanea. La loro proposta rappresenta una lente attraverso cui osservare le contraddizioni del presente e immaginare rotture necessarie. Per il Comitato, l'insurrezione non è un evento singolare o un atto di ribellione spontanea, ma un processo collettivo di risveglio e trasformazione: il punto di partenza per distruggere le vecchie strutture e dare spazio a nuove forme di vita. Ciò che muove la loro riflessione è l'idea di una vita autentica, non condizionata dalle logiche del profitto, della produttività e del controllo statale. La loro critica si rivolge a una società che percepiscono come profondamente alienante, dove le relazioni umane sono mediate da istituzioni oppressive e dove il senso della comunità è stato eroso dalla mercificazione. Il filo rosso è chiaro e molto semplice: solo rompendo con queste logiche è possibile costruire un mondo diverso, basato su relazioni genuine e sulla solidarietà.
Non si tratta di riformare il sistema, ma di abbandonarlo, creando spazi di resistenza e autogestione che possano rappresentare un modello per un'esistenza che sia radicalmente altra.
Il Comitato invita alla costruzione di comunità autonome, spazi di vita collettiva che operano al di fuori delle logiche capitalistiche e statali, dove le persone possono sperimentare modi di vivere alternativi. La forza del loro messaggio risiede nella capacità di proteggere e rivendicare l'immaginazione come atto politico, nella sfida a ripensare la propria esistenza e il proprio ruolo nella società, in una tensione verso l'utopia non intesa come luogo ideale irraggiungibile, ma come stimolo costante a immaginare e costruire il cambiamento. Laboratori sociali, esperimenti di coabitazione, reti di mutuo soccorso, educazione popolare, tutte queste azioni rendono visibile l’impossibile e trasformano l’immaginazione in capacità reale di costruire. Resistere alla paura significa anche diventare architetti di mondi possibili, progettando spazi e relazioni che sfuggono al sistema.
Siamo vivi, e questo basta per essere pericolosi.
Ogni gesto che afferma la vita contro la paura diventa insubordinazione. Non servono martiri né gloria, servono continuità, presenze che durano e corpi che si tengono insieme. Restare vivi significa abitare il presente come luogo del possibile per trasformare la sopravvivenza in insistenza. Perché il potere può minacciare, sorvegliare e isolare, ma non potrà mai comprendere ciò che lega chi ha deciso di non cedere.