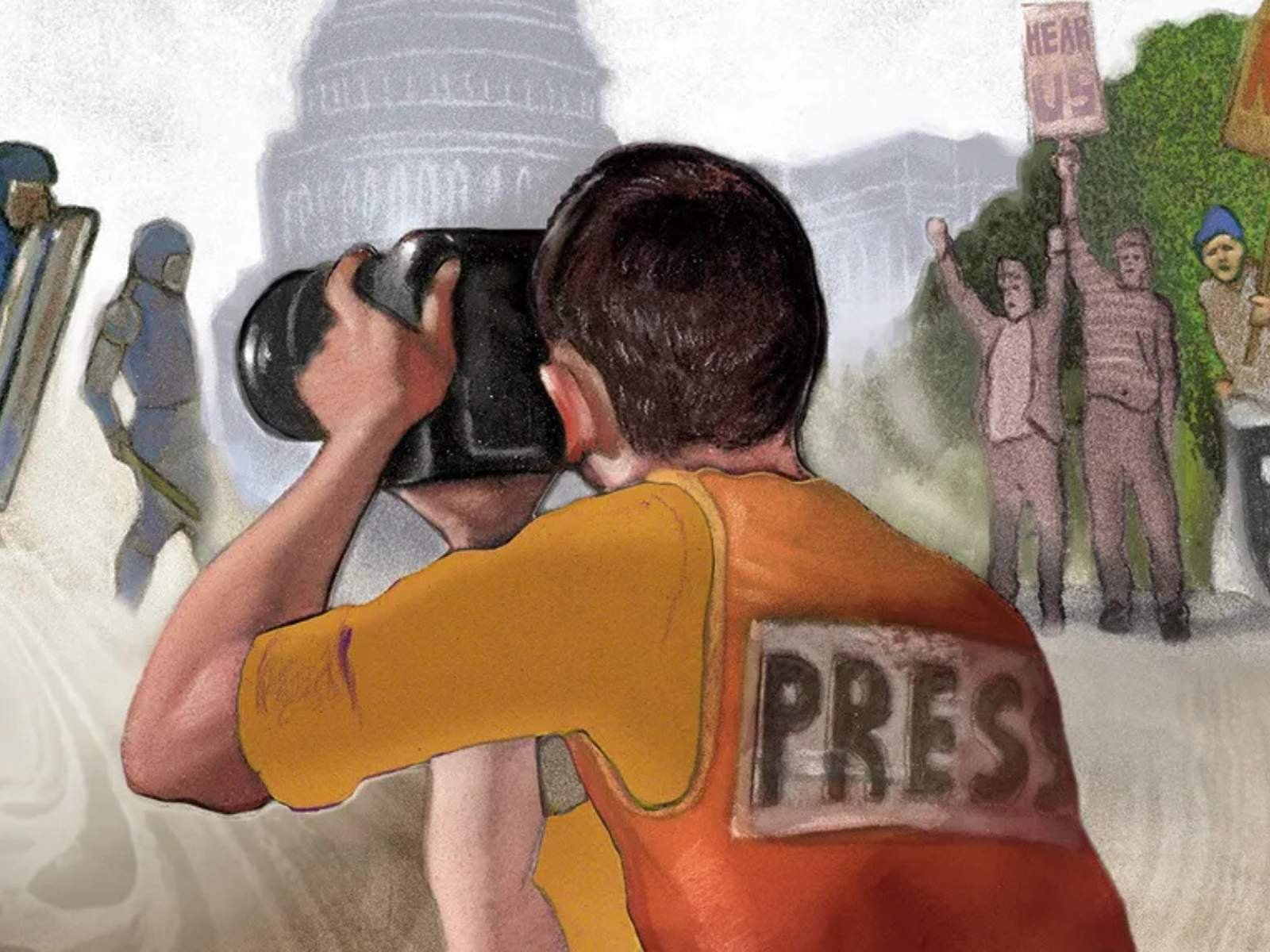Taranto, laboratorio di nuova politica del mare o disastro senza fine?
di Dora Farina, Novella Gianfranceschi, Federica Scannavacca
Sebbene Taranto venga spesso associata ai fumi dell’Ilva, le responsabilità del degrado ambientale non ricadono solo sullo stabilimento siderurgico. Le attività industriali sono spesso rimaste nascoste dietro la struttura architettonica della città che, per anni, ha coperto lo smaltimento incontrollato di rifiuti e sfruttato il mare esclusivamente a vantaggio dell’essere umano, senza considerarlo una risorsa naturale da rispettare.
Una politica del mare lungimirante per Taranto avrebbe potuto prevenire tali abusi, proteggendo il mar Piccolo e il suo delicato ecosistema.
Il bacino salmastro dal grande valore ecologico risulta da decenni fortemente contaminato a causa dello sversamento di sostanze inquinanti, attribuibili in particolar modo all’Arsenale della Marina Militare. Percorrendo il litorale verso sud, il mare scompare alla vista per circa tre chilometri, nascosto da quella che lə residenti chiamano il “muro di Berlino tarantino”: una cinta alta sette metri che delimita i circa 90 ettari dell’Arsenale militare. Secondo i dati di Cnr, Ispra e Arpa Puglia, le acque antistanti la Marina registrano concentrazioni elevate di policlorobifenili (PCB), amianto, arsenico, mercurio e piombo, ben oltre i limiti di sicurezza.
Storia ecologica e culturale del mar Piccolo
Se si guarda Taranto dall’alto somiglia a una clessidra: nell’ampolla superiore si trovano i quartieri Statte, Tamburi e Paolo VI, sede degli impianti ex-Ilva ed Eni; in quella inferiore si estendono la città nuova, le rovine spartane e l’Arsenale della Marina Militare. A collegarle è la città vecchia, un’isola congiunta alla terraferma da due ponti, che collegano il mar Piccolo con il mar Ionio.
Proprio questa configurazione consente la presenza nel mar Piccolo di sorgenti sottomarine di acqua dolce, dette citri, che assicurano una bassa salinità e una naturale regolazione termica. Queste caratteristiche rendono la laguna un habitat straordinario per specie come ippocampi, nudibranchi e, soprattutto, la cozza nera tarantina, riconosciuta Presidio Slow Food dal 2022.
Per il suo potenziale ambientale, il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) ha inserito la laguna tra i “Luoghi del Cuore” e sostiene la sua candidatura a zona protetta, affinché venga finalmente tutelata attraverso una nuova politica del mare. Infatti, a causa delle sue criticità storiche il mar Piccolo è uno dei quarantatre Siti di Interesse Nazionale (SIN), ovvero aree fortemente contaminate che, per estensione o gravità dell’inquinamento, necessitano di interventi di bonifica e messa in sicurezza sotto la diretta competenza dello Stato.
Fallimento delle bonifiche e della gestione pubblica
Come una clessidra, Taranto misura il tempo perso tra promesse di risanamento mai mantenute, a partire dalla bonifica del mar Piccolo.
Nel 2012, un protocollo d’intesa tra Stato e regione Puglia avrebbe dovuto avviare le operazioni, ma - ad oltre dieci anni dalla firma - i risultati sono minimi. La gestione commissariale, affidata a quattro figure dal 2012 ad oggi, è stata segnata da ritardi, sovrapposizioni e scarsa trasparenza. L’attuale commissario Vito Felice Uricchio ha dovuto attendere un anno per entrare nel pieno delle sue funzioni a causa dei ritardi nella nomina governativa della struttura commissariale.
La sua attività è rallentata anche da un debito lasciato dalla commissaria precedente, Vera Corbelli, tra il 2014 e il 2020. Come si legge nel verbale della commissione parlamentare di inchiesta su illeciti ambientali, Corbelli ha dichiarato di aver gestito 214 milioni di euro, provenienti in gran parte dal Fondo di Coesione, lo strumento finanziario europeo destinato a ridurre i divari economici tra le regioni italiane. Le risorse impiegate sono state superiori ai fondi disponibili, generando così un disavanzo.
Nonostante le richieste di accesso agli atti inviate sia al Ministero dell’Ambiente che all’attuale commissario Vito Felice Uricchio a novembre e dicembre 2024, non è stato possibile determinare con precisione l’ammontare del debito. La Corte dei Conti, da parte sua, ha confermato l’assenza di indagini contabili sul processo di bonifica. Tutti questi passaggi sembrano evidenziare un vuoto di governance che impedisce l’attuazione di una politica del mare solida e credibile.
Condizione sulla mitilicoltura
L’inquinamento del mar Piccolo ha gravi ripercussioni soprattutto su mitilicoltorə, custodi di una delle eccellenze gastronomiche locali: la cozza nera tarantina. Da circa due stagioni, i mitili non riescono più a completare il loro ciclo vitale. Oggi, nelle pescherie si trovano quasi esclusivamente “cozze irlandesi”, come indicato dalle etichette del Centro Ittico di Taranto.
La mitilicoltura tarantina è minacciata principalmente da due fattori: l’inquinamento e il cambiamento climatico. Essendo molluschi filtratori, le cozze assorbono i contaminanti presenti nell’acqua, mentre un aumento della temperatura può causarne la morte. Negli ultimi anni, il mar Mediterraneo ha registrato temperature superficiali record, spesso superiori ai 30 gradi, con picchi fino a 5 gradi oltre le medie storiche, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte specie marine.
Per contrastare l’inquinamento, la Regione Puglia ha emanato nel 2016 un’ordinanza che impone rigidi controlli su diossine e PCB, obbligando i mitilicoltorə a spostare le cozze entro il 28 febbraio dal primo seno del mar Piccolo — l’area più favorevole alla crescita ma anche la più contaminata — al secondo seno, meno adatto alle coltivazioni. Come spiega a Voice Over Foundation Vincenzo Guarino, mitilicoltore del sindacato Uila,
“essendo meno profondo e più caldo, spostare nel secondo seno le cozze provoca una diminuzione dell’ossigeno nell’acqua, con conseguente morte dei mitili”.
Una politica del mare efficace per Taranto dovrebbe prevenire tali paradossi, conciliando salute ambientale e sopravvivenza economica.
Tra esempi virtuosi e contraddizioni
Le difficoltà di chi lavora nel settore della mitilicoltura mettono in luce quanto sia falsa la contrapposizione tra interessi economici e tutela ambientale. Lo spiega Roberto Danovaro, biologo marino dell’Università politecnica delle Marche: “La qualità degli ecosistemi marini è fondamentale per la pesca, la balneazione, il turismo e il territorio in generale. Non esiste un conflitto tra ambiente e produzione”.
Danovaro sottolinea anche l’importanza della responsabilità collettiva: “Molti danni agli ecosistemi marini derivano da attività industriali passate, spesso frutto di ignoranza più che di dolo. Decenni fa mancava consapevolezza del valore ambientale del mare e dell’impatto delle nostre azioni.
Oggi la tutela ambientale non è più una scelta, ma un principio costituzionale sancito dagli articoli 9 e 41 della Costituzione”.
Nonostante “l’Italia sia tra i Paesi europei più avanzati nel ripristino degli ambienti marini” continua Danovaro, “la gestione e bonifica del mar Piccolo non sembra essere tra le priorità istituzionali”. Lo conferma il suo mancato inserimento nel progetto MER (Marine Ecosystem Restoration), un piano finanziato con 400 milioni di euro, che rappresenta il più imponente intervento nazionale mai avviato per la conoscenza, la tutela e la rigenerazione degli ecosistemi marini e costieri italiani.
Tra le attività principali vi sono la ricostruzione dei banchi naturali di ostrica piatta (Ostrea edulis) in cinque regioni adriatiche, il completamento della cartografia degli habitat sensibili come la Posidonia oceanica e l’esplorazione delle profondità marine fino a 4000 metri grazie a robot subacquei. Tuttavia, il mar Piccolo di Taranto non è stato coinvolto e, come si può verificare su OpenPNRR — piattaforma indipendente di monitoraggio civico che analizza e rende trasparenti i dati sull’attuazione del Piano in Italia — cercando i progetti finanziati per il Mar Piccolo non si trova nulla, segno di una politica del mare ancora frammentaria, priva di una visione sistemica.
Taranto, laboratorio di nuova politica del mare
Così, dopo oltre un decennio dall’avvio delle bonifiche, l’intera cittadinanza di Taranto attende ancora un risanamento effettivo e chiarezza sui ritardi istituzionali. Il 15 gennaio 2025, diverse associazioni locali, tra cui Legambiente e Libera, si sono riunite in un flash mob davanti al mar Piccolo, pronunciando simbolicamente una sentenza di condanna.
“In nome del popolo inquinato di Taranto si condanna l'inazione, la complicità e il silenzio”,
ha dichiarato un attivista vestito da giudice durante la manifestazione.
Con la campagna “Ecogiustizia subito”, la comunità chiede lo sblocco dei fondi già stanziati, l’accelerazione del processo di bonifica e un impegno concreto per un futuro sostenibile per Taranto, ormai “stanca di continuare a morire a causa dell’inquinamento”.
“A Taranto manca un immaginario condiviso su cosa possa diventare il mar Piccolo per la comunità”, racconta Alessandro Esposito, ricercatore indipendente e membro del collettivo Convocatoria Ecologista. “Come Convocatoria Ecologista, stiamo provando a costruire un immaginario alternativo per Taranto che non settorializzi i problemi, ma li legga dentro lo spazio più ampio dell’abitare: che sia la città, la provincia o la campagna. Lo stesso vale per il mar Piccolo: manca una visione coerente e di lungo periodo sull’intero territorio, e questa assenza ha ostacolato ogni tentativo reale di bonifica”.
Per questo motivo il collettivo organizza laboratori di contronarrazione collettiva come Toxic Bios attraverso cui provano a politicizzare i vissuti individuali nella città, trasformando la “tossicità” dell’inquinamento e della sottrazione di spazi in desiderio comunitario. “Abbiamo immaginato il litorale oltre il muraglione dell’Arsenale, per rialimentare il legame con il mare”. Per Esposito, l’alternativa non è un’altra industria - come quella turistica - bensì
“una città attraversabile, non da vendere ma da abitare”,
dove prendersi cura del territorio significa promuovere forme di cooperazione agroecologica e sostenere la mitilicoltura come tradizione collettiva, al centro di una rinnovata politica del mare. Per Taranto, e non solo.